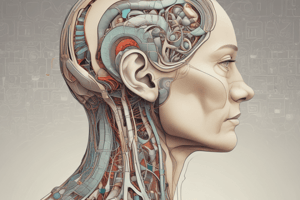Podcast
Questions and Answers
Se la conduzione ossea è normale ma la conduzione aerea è compromessa, il problema si trova nella coclea.
Se la conduzione ossea è normale ma la conduzione aerea è compromessa, il problema si trova nella coclea.
False (B)
Un'ipersensibilità uditiva è caratterizzata da una soglia superiore a 0 dB.
Un'ipersensibilità uditiva è caratterizzata da una soglia superiore a 0 dB.
False (B)
La perdita uditiva minima è classificata tra 16 e 25 dB.
La perdita uditiva minima è classificata tra 16 e 25 dB.
True (A)
Le cause dei difetti sensori-neurali includono problemi al padiglione auricolare.
Le cause dei difetti sensori-neurali includono problemi al padiglione auricolare.
I difetti misti dell'udito comportano una perdita di conduzione solo per via aerea.
I difetti misti dell'udito comportano una perdita di conduzione solo per via aerea.
La differenza di lunghezza (Δl) tra i percorsi delle onde sonore è calcolata esclusivamente in base alla distanza tra le orecchie.
La differenza di lunghezza (Δl) tra i percorsi delle onde sonore è calcolata esclusivamente in base alla distanza tra le orecchie.
La differenza temporale (Δt) tra i segnali sonori che raggiungono le orecchie è inversamente proporzionale alla velocità del suono.
La differenza temporale (Δt) tra i segnali sonori che raggiungono le orecchie è inversamente proporzionale alla velocità del suono.
Un neurone nell'oliva superiore può essere massimamente sensibile a un ritardo interaurale di 400 µs.
Un neurone nell'oliva superiore può essere massimamente sensibile a un ritardo interaurale di 400 µs.
L'oliva laterale (LSO) svolge un ruolo fondamentale nella valutazione della differenza di ampiezza tra suoni di frequenze elevate.
L'oliva laterale (LSO) svolge un ruolo fondamentale nella valutazione della differenza di ampiezza tra suoni di frequenze elevate.
La stima della distanza della sorgente sonora si basa solo sul riverbero e non tiene conto del pre-delay.
La stima della distanza della sorgente sonora si basa solo sul riverbero e non tiene conto del pre-delay.
Maggiore è la distanza tra l'uditore e la sorgente sonora, maggiore è il pre-delay percepito.
Maggiore è la distanza tra l'uditore e la sorgente sonora, maggiore è il pre-delay percepito.
Il collicolo superiore non mantiene una tonotopia simile a quella del nucleo cocleare.
Il collicolo superiore non mantiene una tonotopia simile a quella del nucleo cocleare.
I potenziali evocati corticali tardivi sono visibili intorno ai 10 ms.
I potenziali evocati corticali tardivi sono visibili intorno ai 10 ms.
La corteccia uditiva secondaria (A2) è meno sensibile ai toni puri rispetto alla corteccia uditiva primaria (A1).
La corteccia uditiva secondaria (A2) è meno sensibile ai toni puri rispetto alla corteccia uditiva primaria (A1).
Il corpo genicolato mediale è facilmente visibile nelle registrazioni dei potenziali evocati corticali tardivi.
Il corpo genicolato mediale è facilmente visibile nelle registrazioni dei potenziali evocati corticali tardivi.
La frequenza del segnale sonoro è codificata principalmente attraverso una rappresentazione temporale.
La frequenza del segnale sonoro è codificata principalmente attraverso una rappresentazione temporale.
La corteccia uditiva secondaria (A2) si trova nella parte anteriore del giro temporale superiore.
La corteccia uditiva secondaria (A2) si trova nella parte anteriore del giro temporale superiore.
I neuroni a basse frequenze contattano le cellule ciliate lontane dall'elicotrema.
I neuroni a basse frequenze contattano le cellule ciliate lontane dall'elicotrema.
La discriminazione della frequenza sonora segue un andamento logaritmico.
La discriminazione della frequenza sonora segue un andamento logaritmico.
L'area di Wernicke è prevalentemente situata nell'emisfero destro.
L'area di Wernicke è prevalentemente situata nell'emisfero destro.
Ogni aumento dello 0.2% corrisponde a un aumento di un quarto di tono.
Ogni aumento dello 0.2% corrisponde a un aumento di un quarto di tono.
L'organizzazione tonotopica coinvolge solo la corteccia uditiva primaria (A1).
L'organizzazione tonotopica coinvolge solo la corteccia uditiva primaria (A1).
La corteccia uditiva primaria è situata nel giro trasverso di Heschl ed è chiamata principalmente Area 41.
La corteccia uditiva primaria è situata nel giro trasverso di Heschl ed è chiamata principalmente Area 41.
La corteccia uditiva primaria non ha connettività intrinseca negli strati III, V e VI.
La corteccia uditiva primaria non ha connettività intrinseca negli strati III, V e VI.
I picchi nel segnale acustico possono essere identificati nei primi 5 ms di stimolazione.
I picchi nel segnale acustico possono essere identificati nei primi 5 ms di stimolazione.
L'organizzazione tonotopica della corteccia uditiva primaria è disposta in senso dorso-ventrale.
L'organizzazione tonotopica della corteccia uditiva primaria è disposta in senso dorso-ventrale.
L'area di Wernicke è principalmente coinvolta nella produzione vocale.
L'area di Wernicke è principalmente coinvolta nella produzione vocale.
L'uscita principale della corteccia uditiva primaria avviene dallo strato III.
L'uscita principale della corteccia uditiva primaria avviene dallo strato III.
Le bande sensibili all'eccitazione binaurale sono alternate a bande in cui si ha una risposta eccitatoria per la stimolazione ipsilaterale.
Le bande sensibili all'eccitazione binaurale sono alternate a bande in cui si ha una risposta eccitatoria per la stimolazione ipsilaterale.
La corteccia uditiva ha una risposta lenta allo stimolo con alta latenza.
La corteccia uditiva ha una risposta lenta allo stimolo con alta latenza.
I meccanismi di localizzazione sonora nella corteccia uditiva sono simili a quelli delle cellule semplici della corteccia visiva.
I meccanismi di localizzazione sonora nella corteccia uditiva sono simili a quelli delle cellule semplici della corteccia visiva.
L'area di Broca non ha alcun ruolo nella pianificazione della risposta linguistica.
L'area di Broca non ha alcun ruolo nella pianificazione della risposta linguistica.
Gli impianti cocleari stimulano direttamente la coclea non funzionante.
Gli impianti cocleari stimulano direttamente la coclea non funzionante.
La formazione reticolare è coinvolta nelle risposte non coscienti come il risveglio per un rumore.
La formazione reticolare è coinvolta nelle risposte non coscienti come il risveglio per un rumore.
Gli impianti nucleari vengono impiantati nella coclea e progettati per ripristinare la tonotopia uditiva.
Gli impianti nucleari vengono impiantati nella coclea e progettati per ripristinare la tonotopia uditiva.
Il flusso d'aria costante è fondamentale per la fonazione autonoma.
Il flusso d'aria costante è fondamentale per la fonazione autonoma.
Il sistema dei riflessi di orientamento dirige la testa verso la sorgente del suono.
Il sistema dei riflessi di orientamento dirige la testa verso la sorgente del suono.
La tonotopia si riferisce alla capacità dell'impianto cocleare di attivare aree corticali per specifiche frequenze.
La tonotopia si riferisce alla capacità dell'impianto cocleare di attivare aree corticali per specifiche frequenze.
Un catetere a spirale con elettrodi viene impiantato nella corteccia uditiva per stimolare il nervo acustico.
Un catetere a spirale con elettrodi viene impiantato nella corteccia uditiva per stimolare il nervo acustico.
Il sistema nervoso coinvolge vie centrali che gestiscono sia l'integrazione cosciente che inconscia.
Il sistema nervoso coinvolge vie centrali che gestiscono sia l'integrazione cosciente che inconscia.
La respirazione è coordinata dalle aree motorie per produrre fonazione autonoma.
La respirazione è coordinata dalle aree motorie per produrre fonazione autonoma.
Flashcards
Differenza di Lunghezza Interaurale (Δl)
Differenza di Lunghezza Interaurale (Δl)
La differenza di lunghezza dei percorsi sonori che raggiungono le due orecchie. Dipende dalla distanza tra le orecchie e dall'angolo della sorgente sonora rispetto al piano sagittale.
Ritardo Interaurale (ITD)
Ritardo Interaurale (ITD)
Il tempo che intercorre tra l'arrivo del suono a un orecchio e l'arrivo del suono all'altro orecchio. È direttamente proporzionale alla differenza di lunghezza interaurale e inversamente proporzionale alla velocità del suono.
Neurone Sintonizzato sull'ITD
Neurone Sintonizzato sull'ITD
Un neurone nell'oliva superiore che è sensibile a specifici ritardi interaurali. Risponde in modo maggiore quando il ritardo corrisponde alla sua 'frequenza caratteristica'.
Differenza di Intensità Interaurale (IID)
Differenza di Intensità Interaurale (IID)
Signup and view all the flashcards
Oliva Laterale (LSO)
Oliva Laterale (LSO)
Signup and view all the flashcards
Pre-Delay
Pre-Delay
Signup and view all the flashcards
Collicolo Superiore
Collicolo Superiore
Signup and view all the flashcards
Audiogramma: interpretazione
Audiogramma: interpretazione
Signup and view all the flashcards
Difetto di Conduzione
Difetto di Conduzione
Signup and view all the flashcards
Difetto Sensori-Neurale
Difetto Sensori-Neurale
Signup and view all the flashcards
Livelli di Perdita Uditiva
Livelli di Perdita Uditiva
Signup and view all the flashcards
Effetto dell'Età sull'Udito
Effetto dell'Età sull'Udito
Signup and view all the flashcards
Corteccia Uditiva Primaria (A1)
Corteccia Uditiva Primaria (A1)
Signup and view all the flashcards
Organizzazione Tonotopica di A1
Organizzazione Tonotopica di A1
Signup and view all the flashcards
Organizzazione Rostro-Caudale di A1
Organizzazione Rostro-Caudale di A1
Signup and view all the flashcards
Risposta di A1 allo Stimolo
Risposta di A1 allo Stimolo
Signup and view all the flashcards
Corteccia Uditiva Secondaria (A2)
Corteccia Uditiva Secondaria (A2)
Signup and view all the flashcards
Area di Wernicke
Area di Wernicke
Signup and view all the flashcards
Area di Broca
Area di Broca
Signup and view all the flashcards
Fascicolo Arcuato
Fascicolo Arcuato
Signup and view all the flashcards
Stream Dorsale (Fonazione)
Stream Dorsale (Fonazione)
Signup and view all the flashcards
Ruolo dell'Area di Broca nello Stream Dorsale
Ruolo dell'Area di Broca nello Stream Dorsale
Signup and view all the flashcards
Esecuzione dello Stream Dorsale
Esecuzione dello Stream Dorsale
Signup and view all the flashcards
Riflessi di Orientamento
Riflessi di Orientamento
Signup and view all the flashcards
Formazione Reticolare
Formazione Reticolare
Signup and view all the flashcards
Ruolo dell'Ipotalamo e della Corteccia Limbica nell'Udito
Ruolo dell'Ipotalamo e della Corteccia Limbica nell'Udito
Signup and view all the flashcards
Impianti Cocleari
Impianti Cocleari
Signup and view all the flashcards
Funzionamento degli Impianti Cocleari
Funzionamento degli Impianti Cocleari
Signup and view all the flashcards
Elaborazione del Segnale nell'Impianto Cocleare
Elaborazione del Segnale nell'Impianto Cocleare
Signup and view all the flashcards
Ripristino della Tonotopia Corticale
Ripristino della Tonotopia Corticale
Signup and view all the flashcards
Elaborazione Gerarchica dei Potenziali Evocati Corticali Tardivi
Elaborazione Gerarchica dei Potenziali Evocati Corticali Tardivi
Signup and view all the flashcards
Rappresentazione Spaziale delle Frequenze
Rappresentazione Spaziale delle Frequenze
Signup and view all the flashcards
Sintonizzazione Neuronale delle Frequenze
Sintonizzazione Neuronale delle Frequenze
Signup and view all the flashcards
Discriminazione Logaritmica in Frequenza
Discriminazione Logaritmica in Frequenza
Signup and view all the flashcards
Corpo Genicolato Mediale (MGB)
Corpo Genicolato Mediale (MGB)
Signup and view all the flashcards
Mappe Tonotopiche
Mappe Tonotopiche
Signup and view all the flashcards
Elaborazione Gerarchica del Suono
Elaborazione Gerarchica del Suono
Signup and view all the flashcards
Study Notes
Sensibilità Uditiva: Vie Centrali ed Elaborazione del Segnale Sonoro
- Due vie principali per la percezione conscia del suono: controlaterale/bilaterale (via consapevole) e ipsilaterale (via polisinaptica).
- La via consapevole è il percorso principale, inizialmente controlaterale, ma rapidamente bilaterale.
- La via polisinaptica ipsilaterale è più lenta, coinvolgendo la formazione reticolare per risposte riflesse, emotive e autonome.
- Il nucleo cocleare ventrale anteriore è un punto cruciale dello smistamento bilaterale, assicurando una rappresentazione bilaterale del segnale uditivo.
- I potenziali microfonici sono registrazioni extracellulare, non variazioni di potenziale di membrana.
Effetto della Capacità di Membrana sulla Propagazione del Segnale
- L'esperimento dell'assone di calamaro dimostra come l'iniezione di corrente e la registrazione vicina evidenziano una variazione simile alla corrente iniettata, soprattutto con correnti oscillanti.
- La capacità di membrana, sebbene piccola per ogni segmento, diventa significativa su una vasta superficie di membrana, causando una filtrazione del segnale all'aumentare della distanza dell'elettrodo.
Risposta delle Cellule Ciliate a Stimoli Costanti
- In risposta a uno stimolo costante e prolungato, le cellule ciliate scaricano alla loro frequenza, proporzionale all'intensità dello stimolo; questo segue la legge di Stevens.
Tonotopia e Campi Recettivi nel Nervo Acustico
- Il nervo acustico evidenzia una forte divergenza e mantiene una tonotopia; si può misurare l'intensità minima per lo scarico di ogni fibra.
- Intensità elevate stimolano molteplici fibre, mentre quelle minori attivano selettivamente singole fibre.
Organizzazione del Nucleo Cocleare
- Le fibre del nucleo cocleare si suddividono in una branca dorsale (proietta al collicolo inferiore controlaterale) e una ventrale (proietta alle olive).
- Il nucleo cocleare mantiene la tonotopia del nervo acustico.
- Esistono diversi tipi di neuroni nel nucleo cocleare, ciascuno con risposte distinte, derivanti da una singola fibra del nervo uditivo.
Elaborazione dell'Informazione nei Nuclei Uditivi
- Il nucleo laterale riceve afferenze eccitatorie ipsilaterali e inibitorie controlaterali per il confronto dell'intensità del segnale.
- Il complesso olivare superiore, in particolare il nucleo olivare superiore mediale, riceve afferenze eccitatorie ipsilaterali e gioca un ruolo centrale nella localizzazione uditiva, valutando le differenze temporali tra le orecchie.
Sistema Olivo-Cocleare e Controllo Efferente
- Il sistema olivo-cocleare opera una inibizione della risposta diretta della coclea.
- La stimolazione delle vie crociate (controlaterali) riduce l'ampiezza del potenziale d'azione nelle due orecchie; la stimolazione non crociata (ipsilaterale) ha effetto sull'orecchio stimolato.
- L'effetto del sistema olivo-cocleare è appiattire la curva di risposta della coclea, diminuendo la sensibilità alle intensità basse e migliorando la discriminazione alle intensità elevate.
Localizzazione dei Suoni: Meccanismi Temporali, di Ampiezza e di Frequenza
- La localizzazione dei suoni si basa su tre principali tipi di variazioni nel segnale sonoro: differenze temporali interaurali (ITD), differenze di intensità interaurali (IID) e variazioni di frequenza.
- L'ITD si basa sull'individuazione del ritardo temporale tra le due orecchie.
- L'IID si basa sulla differenza di intensità del suono nelle due orecchie.
- Variazioni di frequenza consentono una discriminazione più precisa.
Collicolo Inferiore e Superiore: Tonotopia e Integrazione Sensoriale
- Il collicolo inferiore mantiene una tonotopia simile al nucleo cocleare e all'oliva, e funge da substrato per il collicolo superiore.
- Il collicolo superiore integra informazioni uditive, visive e somatosensoriali per mappare lo spazio.
- La mappa visiva, nello strato superficiale, controlla le saccadi e l'orientamento degli occhi.
- Uno strato più profondo contiene una mappa uditiva con la stessa organizzazione azimutale ed elevativa della mappa visiva.
Corpo Genicolato Mediale (CGM): Il Talamo Uditivo
- Il CGM, spesso chiamato talamo uditivo, riceve afferenze dal collicolo inferiore ed è organizzato tonotopicamente.
Organizzazione Tonotopica e Specializzazione Funzionale
- Anche nel CGM, i neuroni sono sintonizzati su specifiche frequenze, con curve di risposta che definiscono la loro frequenza caratteristica.
- La corteccia uditiva primaria (A1) si specializza nell'analisi di frequenza.
- La corteccia uditiva secondaria (A2) si specializza nell'analisi temporale del suono.
Potenziali Evocati del Tronco Encefalico (BAEPs): Registrazione Non Invasiva del Transito del Segnale
- I BAEPs monitorano il transito dei segnali uditivi attraverso diverse stazioni.
- Sono una tecnica non invasiva che registra i potenziali nervosi consecutivamente.
- La tecnica usa un elettrodo sulla cute retroauricolare e uno di riferimento sulla fronte.
- Lo stimolo è un suono breve.
Corteccia Uditiva Primaria (A1): Organizzazione e Funzioni
- La corteccia uditiva primaria (A1), situata nel giro trasverso di Heschl, è strutturata in sei strati ed è fortemente connessa intrinsecamente.
- L'output principale deriva dallo strato V, che proietta alla corteccia uditiva secondaria e ad altre aree del lobo temporale.
- L'organizzazione tonotopica è presente nella corteccia A1, dove diverse bande rispondono a diverse frequenze.
- È presente anche un'organizzazione rostro-caudale, alternando bande che rispondono all'eccitazione binaurale (EE) o all'eccitazione controlaterale/inibizione ipsilaterale (EI).
Corteccia Uditiva Secondaria (A2) e Aree del Linguaggio
- Lateralmente alla corteccia uditiva primaria (A1), nel giro temporale superiore, si trova la corteccia uditiva secondaria (A2).
- Più posteriormente, si trova l'area di Wernicke, connessa all'area di Broca tramite il fascicolo arcuato.
Potenziali Evocati Corticali (Tardivi): Elaborazione Gerarchica
- I potenziali evocati corticali tardivi mostrano un'elaborazione gerarchica del segnale uditivo.
- Le prime risposte sono visibili intorno ai 5 ms.
- Successivamente si osserva attività nella corteccia uditiva primaria (A1), e poi nelle aree corticali secondarie.
- È presente un'elaborazione gerarchica.
Mappe Tonotopiche Multiple, Analisi Temporale, Localizzazione e Area di Wernicke
- La corteccia uditiva secondaria (A2) presenta mappe tonotopiche multiple, occupandosi di analisi temporali complesse, localizzazione e riconoscimento di pattern sonori.
- L'area di Wernicke, localizzata nel giro temporale superiore, giocando un ruolo nella comprensione del linguaggio.
Codifica della Frequenza del Segnale Sonoro
- La frequenza del segnale sonoro è codificata principalmente attraverso una rappresentazione spaziale (diverse frequenze oscilano parti specifiche della membrana basilare, attivano diversi neuroni).
- Sintonizzazione neuronale: neuroni sintonizzati su specifiche frequenze e rispondono alle cellule ciliate corrispondenti. - Discriminazione logaritmica: La discriminazione in frequenza segue un andamento logaritmico - Nella zona del parlato e del cantato si riesce a distinguere un salto di 0,2%.
Codifica Tempo-Frequenza: La Necessità di un Compromesso
- L'analisi dei suoni complessi richiede un equilibrio tra la codifica temporale e quella di frequenza.
Analisi Temporale vs Analisi di Frequenza
- Per una precisa codifica della frequenza, è necessario analizzare diversi cicli dell'oscillazione, richiedendo l'estensione dell'analisi nel tempo.
- Le trasformate di Fourier, usate per analizzare le frequenze, necessitano dell'integrazione del segnale su tutto il tempo.
- Per capirne l'inizio e la fine, e necessario campionare il segnale nel tempo, sacrificando la precisione nell'analisi di frequenza.
Compromesso Corteccia Primaria-Secondaria
- La corteccia uditiva primaria (A1) è specializzata nell'analisi di frequenza.
- La corteccia uditiva secondaria (A2) si concentra sull'analisi temporale.
- Entrambe le cortecce analizzano sia la frequenza che il tempo, adattandosi alle caratteristiche del segnale.
Esempi Pratici e Analisi Wavelet
- Eventi critici come click asincroni richiedono una risoluzione temporale elevata.
- Suoni complessi richiedono l'analisi in frequenza.
- L'analisi Wavelet cerca di massimizzare la risoluzione sia nel tempo sia nella frequenza.
Volontarietà e Involontarietà nella Discriminazione
- La discriminazione dei suoni può avvenire sia volontariamente che involontariamente.
- Messaggi subliminali possono influenzare il comportamento a livello inconscio.
- È complesso definire il confine tra elaborazione volontaria e involontaria nella percezione uditiva.
Aree di Broca e Wernicke: Afasie e Funzioni del Linguaggio
- Le lesioni delle aree di Broca e Wernicke portano ad afasie diverse.
- Afasia di Broca (motoria): difficoltà nella produzione linguistica, eloquio non fluente e lento, con errori fonetici e nella coordinazione.
- Afasia di Wernicke (recettiva): difficoltà nella comprensione linguistica, eloquio fluente ma incomprensibile, con neologismi e parole non corrette.
Elaborazione del Linguaggio: Interpretazione e Fonazione
- L'elaborazione del linguaggio coinvolge due stream corticali, simili a quelli della visione: stream ventrale (interpretazione) e stream dorsale (fonazione).
- Stream ventrale: aree uditive bilaterali alla corteccia parieto-temporale superiore.
- Stream dorsale: aree uditive all'area di Broce, coinvolte nella pianificazione della risposta, aree motorie per la produzione e la coordinazione.
- Entrambe i pathways implicano l'emisfero dominante (sinistro), anche se l'emisfero non dominante partecipa all'interpretazione.
Vie Centrali: Integrazione Conscia e Inconscia
- Oltre alla via dell'interpretazione cosciente, esistono vie sottocorticali che coinvolgono riflessi di orientamento, formazione reticolare e ipotalamo/corteccia limbica.
- I riflessi di orientamento vengono dall'oliva superiore ai collicoli, dirigendo l'attenzione verso i suoni improvvisi.
- La formazione reticolare è una via polisinaptica che proietta al talamo non-specifico e gioca un ruolo nelle risposte non coscienti.
- Ipotalamo/corteccia limbica sono implicati nelle risposte vegetative, endocrine, ed emotive.
Impianti Cocleari: Bypassing la Coclea e Ripristino della Tonotopia
- Gli impianti cocleari bypassano la coclea non funzionante stimolando direttamente i nervi acustici.
- Essenzialmente, un catetere a spirale con elettrodi viene impiantato nella coclea per stimolare le aree del nervo.
L'Audiogramma: Misura Clinica della Sensibilità Uditiva
- L'audiogramma è uno strumento clinico che misura la soglia uditiva a diverse frequenze.
- La sensibilità uditiva non è uniforme in tutto lo spettro udibile.
- Il normale audiogramma si presenta con una curva vicina ai 0db.
Soglia Uditiva e Campo Udibile
- La sensibilità (soglia) uditiva è minima a medie frequenze e aumenta sia alle alte che alle basse.
- Il campo udibile si estende dalla soglia uditiva alla soglia del dolore.
Audiogramma Clinico: Riferimento Normalizzato a 0 dB
- Normalizzazione a 0 dB per la soglia uditiva per poter confrontare le persone sane.
- In pratica, l'audiometro clinico è calibrato per poter adattare l'intensità del suono ai diversi valori di frequenza.
Audiogramma Vocale: Riconoscimento di Parole
- Valuta la capacità di riconoscimento di parole a diverse intensità sonore.
- Le persone sane riconoscono le parole intorno ai 20 dB.
- Le persone con difficoltà uditive hanno bisogno di intensità molto più elevate.
Audiometria Convenzionale: Test con Toni Puri e Risposta del Soggetto
- La procedura si svolge tramite cuffie, in ambiente silente, con un interruttore da premere da parte del soggetto in presenza di un suono.
- Intensità variabile dei toni puri per determinare la soglia uditiva di ciascun orecchio.
Anatomia della Sordità: Difetti di Conduzione e Sensorineurali
- Difetti di conduzione: problemi nella trasmissione del suono verso la coclea (es: cerume, problemi al padiglione auricolare, perforazioni del timpano, malfunzionamento degli ossicini).
- Difetti sensorineurali: problemi a livello della coclea o del nervo acustico (es: lesioni cocleari, danni al nervo acustico).
- Audiogramma: fornisce informazioni sulla conduzione aerea e ossea per determinare il tipo di perdita uditiva.
Effetto dell'Età sulla Sensibilità Uditiva
- La sensibilità alle alte frequenze tende a diminuire con l'età.
Livelli di Perdita Uditiva
- La perdita uditiva viene classificata in livelli: minima, leggera, moderata, severa e grave, in base ai dB di deficit.
Fastidio per i Suoni Forti nei Soggetti con Perdita Uditiva
- La soglia del dolore resta a 120dB, mentre la soglia uditiva aumenta a causa della perdita.
- Aumenti eccessivi del volume del suono sono percepiti come fastidiosa o dolorosa nel soggetto con perdita uditiva.
Discussione sulla Tonotopia Cocleare e la Conduzione Ossea
- La tonotopia cocleare potrebbe essere alterata se lo stimolo non proviene dalla porta ovale.
- Le vibrazioni della coclea innescano il movimento attraverso la finestra ovale e quella rotonda.
- Sia le cellule ciliate che le fibre nervose hanno una loro tonotopia.
- La soglia di 0 dB per la conduzione ossea è stata stabilita tramite esperimenti con soggetti sani.
- La trasmissione del suono nell'aria differisce dalla conduzione ossea a causa di percorsi e meccanismi diversi.
Timpanometria: Valutazione della Cedevolezza Timpanica
- La timpanometria misura la cedevolezza della membrana timpanica.
- Procedura: attraverso cuffie che pressurizzano l'orecchio per misurare la cedevolezza a 226Hz.
- Soggetti sani: valori di cedevolezza entro parametri normali.
- Accumulo di liquido nell'orecchio medio: la curva timpanometrica sarà piatta.
- Tromba di Eustachio chiusa: la curva si sposta verso pressioni negative.
- Scopo: identificare problemi di conduzione nell'orecchio medio.
Emissioni Otoacustiche: Attività delle Cellule Ciliate Esterne
- Le emissioni otoacustiche (OAE) permettono di valutare l'attività delle cellule ciliate esterne.
- Procedura: stimolazione uditiva con audiometriche e analisi della risposta.
- Le cellule ciliate esterne sono contrattili e possono emettere suoni come risposta a stimoli.
- Analisi delle OAE per discriminare la salute della coclea.
Potenziali Evocati Uditivi: Valutazione dell'Integrità del Percorso Neurale
- I potenziali evocati uditivi (AEP) valutano la salute del percorso neurale uditivo.
- Procedura: registrazioni delle risposte nervose a stimoli acustici.
- Registrazione: uso di elettrodi sullo scalpo.
- Stimolazione: suoni di varie frequenze.
- Analisi: analisi di picchi corrispondenti al transito del segnale.
- Utilità: per rilevare perdite uditive a varie frequenze, anche in soggetti non collaborativi.
Auditory Brainstem Response (ABR)
- Risposta normale in soggetti sani con picchi evidenti in diverse stazioni del tronco encefalico.
- Nell'acustico neurinoma, l'ABR mostra blocchi dalla seconda stazione.
- Deficit complessi non mostrano picchi anche ad altissime intensità.
Potenziali Evocati Uditivi Corticali
- Registrazione dei potenziali corticali con elettrodi sullo scalpo.
- Stimolazione con toni brevi ad intensità variabile.
- Analisi delle risposte corticali, che hanno ampiezza correlata all'intensità dello stimolo.
- Media sincronizzata per migliorare il segnale rimuovendo le componenti non correlate allo stimolo.
- Interpretazione dei picchi (N200, N300) per la localizzazione delle sorgenti.
Studying That Suits You
Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.