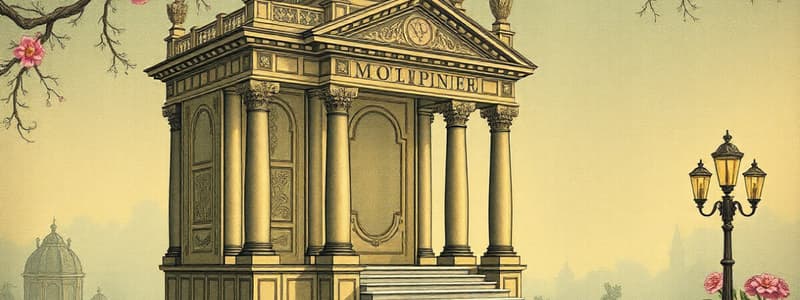Podcast
Questions and Answers
Quale dei seguenti elementi caratterizza il significato forte del principio del contraddittorio nel processo penale?
Quale dei seguenti elementi caratterizza il significato forte del principio del contraddittorio nel processo penale?
- La garanzia di essere avvisati della conclusione delle indagini preliminari.
- La possibilità di conoscere il verbale degli atti di indagine.
- La partecipazione attiva delle parti alla formazione della prova. (correct)
- Il diritto del difensore di essere presente ad un atto di indagine.
In che modo il principio di immediatezza influenza la composizione del collegio giudicante durante il dibattimento?
In che modo il principio di immediatezza influenza la composizione del collegio giudicante durante il dibattimento?
- Stabilisce che alla deliberazione della sentenza partecipino gli stessi giudici che hanno assistito al dibattimento. (correct)
- Impone che il dibattimento sia rinnovato integralmente se cambia la composizione del collegio.
- Richiede che i giudici supplenti siano sempre presenti a tutte le udienze.
- Permette che i giudici possano delegare ad altri la partecipazione al dibattimento.
Cosa implica il principio di concentrazione nel contesto del processo penale?
Cosa implica il principio di concentrazione nel contesto del processo penale?
- La riduzione del numero di testimoni ammessi nel processo.
- L'assenza di intervalli prolungati tra l'assunzione delle prove, la discussione finale e la deliberazione della sentenza. (correct)
- L'obbligo di concludere il processo entro un termine perentorio.
- La necessità di acquisire tutte le prove nel minor tempo possibile.
Secondo l'art. 526 c.p.p., quali prove può utilizzare il giudice ai fini della deliberazione?
Secondo l'art. 526 c.p.p., quali prove può utilizzare il giudice ai fini della deliberazione?
Quali sono i limiti temporali previsti per il rinvio della trattazione dei processi nei quali l'indulto esaurisce la pena da eseguire?
Quali sono i limiti temporali previsti per il rinvio della trattazione dei processi nei quali l'indulto esaurisce la pena da eseguire?
Flashcards
Significato debole del principio del contraddittorio
Significato debole del principio del contraddittorio
Assicura il diritto del difensore di essere presente ad un atto di indagine o di conoscere il relativo verbale.
Significato forte del principio del contraddittorio
Significato forte del principio del contraddittorio
Comporta la partecipazione delle parti alla formazione della prova, specialmente nell'esame incrociato.
Oralità nel diritto processuale
Oralità nel diritto processuale
La forma verbale di comunicazione del pensiero, tramite la pronuncia di parole destinate ad essere udite.
Principio di immediatezza
Principio di immediatezza
Signup and view all the flashcards
Principio di concentrazione
Principio di concentrazione
Signup and view all the flashcards
Study Notes
Il Principio del Contraddittorio
- Il principio del contraddittorio si manifesta sia in una forma debole, durante le indagini preliminari, sia in una forma forte, nella fase dibattimentale.
- Nella sua accezione debole, garantisce al difensore il diritto di presenziare agli atti di indagine e di accedere ai relativi verbali.
- La conoscenza dei verbali degli atti di indagine si completa con l'invio dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, come previsto dall'art. 415 bis c.p.p.
- Nella sua accezione forte, il principio del contraddittorio implica la partecipazione delle parti alla formazione della prova.
- Nel caso di prove orali, la partecipazione avviene attraverso l'esame incrociato.
- Le domande vengono poste, in ordine, dalla parte che ha richiesto l'esame (esame diretto), dalla controparte (controesame) e nuovamente dalla parte richiedente (riesame).
- L'attuazione del principio del contraddittorio richiede il riconoscimento di diritti strumentali, tra cui il diritto di ottenere l'ammissione della prova da parte del giudice (orale, documentale o reale) e il diritto di ottenere l'ammissione della prova contraria.
- Ulteriore diritto strumentale è quello di porre domande durante l'esame diretto e il controesame.
- L'esercizio del diritto di porre domande è sotto il controllo del Presidente dell'organo collegiale, che ne valuta la pertinenza e l'ammissibilità.
Il Principio di Oralità
- Per "oralità" si intende la comunicazione verbale di pensieri attraverso parole destinate all'ascolto.
- In contrapposizione, la "scrittura" è la comunicazione di pensieri tramite segni visibili, alfabetici o ideografici.
- L'espressione orale può essere documentata.
- La lettura di uno scritto può essere considerata una forma di oralità derivata.
- La riproduzione di una registrazione si avvicina all'oralità originaria, pur con delle differenze, in quanto l'ascoltatore non può partecipare attivamente all'esame incrociato.
- La lettura di un verbale o l'audizione di una registrazione non equivalgono all'oralità nel suo pieno significato.
- L'oralità è la regola generale per le dichiarazioni nel codice di rito.
- Esistono prove che non sono orali, come le prove reali (corpo del reato, oggetti pertinenti al reato, documenti), le attività irripetibili, gli accertamenti tecnici, le perizie e le ispezioni.
Il Principio di Immediatezza
- Il principio di immediatezza si articola in due aspetti principali.
- In primo luogo, vi deve essere identità fisica tra il giudice che decide e quello che assiste al dibattimento.
- In secondo luogo, la decisione deve basarsi sulle prove acquisite durante il dibattimento.
Identità Tra il Giudice che Assiste all'Assunzione delle Prove e Quello che Decide
- L'art. 525, co. 2 c.p.p. stabilisce il principio di identità tra il giudice che decide e quello che ha assistito al dibattimento.
- La norma prevede che "alla deliberazione della sentenza concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento”.
- Il codice non disciplina espressamente la sostituzione di un giudice monocratico o di un membro del collegio giudicante durante il dibattimento.
- In dottrina e giurisprudenza, si ritiene necessario rinnovare il dibattimento nel caso di sostituzione del giudice, come espresso dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 17 del 3 febbraio 1994).
- Le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato che, su richiesta di una delle parti, l'esame dei dichiaranti deve essere rinnovato, se possibile.
- In tal caso, i verbali delle prove raccolte dal primo giudice non possono essere utilizzati per la decisione tramite semplice lettura.
- Le norme sui giudizi in Corte d'Assise prevedono la partecipazione di giudici "supplenti" in caso di impedimento dei giudici "titolari".
- Se si verifica l'impedimento di uno o più giudici e vengono inseriti i giudici supplenti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia, salvo esplicita revoca.
Decisione Basata su Prove Legittimamente Acquisite in Dibattimento
- L'art. 526 c.p.p. esprime un altro aspetto del principio di immediatezza, stabilendo che il giudice può utilizzare ai fini della deliberazione solo le prove legittimamente acquisite nel dibattimento.
- Il codice ammette l'utilizzo di tutte le prove legittimamente acquisite in dibattimento, non solo quelle orali.
- Il codice dimostra una preferenza per le prove raccolte oralmente in dibattimento, ma non esclude le prove precostituite, come i verbali degli atti irripetibili.
Il Principio della Concentrazione
- Il principio di concentrazione richiede che non vi siano intervalli temporali significativi tra l'assunzione delle prove, la discussione finale e la deliberazione della sentenza.
- Questo principio garantisce che la decisione sia il risultato fedele del processo, evitando che l'attenzione del giudice diminuisca.
- L'art. 477, co. 1 c.p.p., stabilisce che "quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il Presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo".
- L'art. 525, co. 1 c.p.p., prevede che "la sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento".
- Il dibattimento è caratterizzato dalla concentrazione, cioè dalla riduzione dei tempi morti.
- Per garantire la massima celerità, il processo deve proseguire nel giorno feriale successivo, se le condizioni dei ruoli lo consentono.
- In caso di necessità "assoluta", il rinvio non dovrebbe superare il decimo giorno non festivo.
- Questi principi devono essere coordinati con altre norme.
- L'art. 508 c.p.p. stabilisce che il rinvio per una perizia non può superare i 60 giorni.
- L'art. 509 c.p.p. prevede la sospensione del dibattimento per il tempo strettamente necessario all'acquisizione di prove non tempestivamente acquisibili.
- L'art. 519 c.p.p. prevede un termine "a difesa" non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta.
- L'art. 520 c.p.p. ribadisce tali termini in caso di contumacia o assenza dell'imputato, con notifica del verbale di udienza contenente la contestazione.
Rinvio della Trattazione dei Processi per Indulto
- È stato introdotto un meccanismo per favorire i procedimenti per alcuni tipi di reato.
- Questo meccanismo prevede un istituto denominato "rinvio della trattazione dei processi".
- Il rinvio riguarda i reati commessi fino al 2 maggio 2006, per i quali ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'indulto e la pena eventualmente da infliggere può essere contenuta entro i tre anni.
- Il rinvio della trattazione si applica solo ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di sospensione (26 luglio 2008).
- Il rinvio non è imposto direttamente dal legislatore, ma è rimesso all'indicazione dei dirigenti degli uffici giudicanti.
- I dirigenti possono individuare criteri e modalità di trattazione dei processi, tenendo conto della gravità del reato, del pregiudizio derivante dal ritardo nella formazione della prova e dell'interesse della persona offesa.
La Regolamentazione del Rinvio
- Il legislatore ha regolamentato il nuovo istituto del rinvio nel seguente modo.
- Il rinvio non può durare più di 18 mesi.
- Il termine di prescrizione del reato è sospeso per tutta la durata del rinvio.
- La parte civile costituita può trasferire l'azione in sede civile, con termini abbreviati e precedenza di trattazione.
- In questo caso, non si applica la sospensione del processo civile in attesa dell'esito di quello penale.
- Il rinvio non è ammesso se l'imputato si oppone o se il dibattimento è già stato dichiarato chiuso.
Applicabilità dell'Indulto e Patteggiamento
- Una normativa speciale è stata introdotta per i processi in primo grado relativi a reati per i quali, in caso di condanna, si applicherebbe l'indulto previsto dalla l. n. 241/06.
- L'imputato e il P.M. possono presentare richiesta di patteggiamento nella prima udienza successiva al 26 luglio 2008, se ritengono che la pena possa rientrare nei limiti dell'indulto.
- La richiesta può essere formulata anche se già presentata in precedenza, con dissenso del P.M. o rigetto del giudice, purché non sia una mera riproposizione della precedente.
Durata e Prosecuzione del Dibattimento
- Se non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il Presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo.
- Il giudice può sospendere il dibattimento solo per ragioni di assoluta necessità e per un massimo di dieci giorni, festivi esclusi.
- Il Presidente comunica oralmente gli avvisi e l'ausiliario ne dà menzione nel verbale, sostituendo citazioni e notificazioni per i presenti.
- I termini stabiliti dalla norma hanno carattere ordinatorio e la loro inosservanza non causa nullità o decadenza.
- Il rispetto dei termini deve essere valutato in relazione all'attività gravante sull'ufficio giudiziario.
- In applicazione dell'art. 148, co. 5° c.p.p., le disposizioni relative al rinvio del dibattimento vengono date oralmente e riportate nel verbale, realizzando così le notificazioni e comunicazioni richieste dalla legge.
Studying That Suits You
Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.